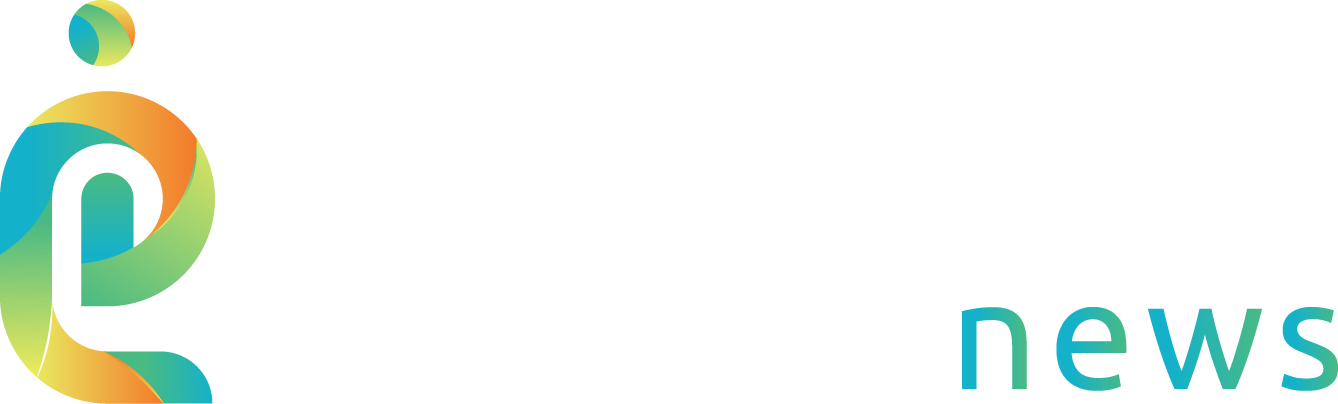Realizzare un impianto solare a concentrazione in una raffineria di petrolio consentirebbe di ridurre di oltre il 10% le emissioni di anidride carbonica e la quantità di metano impiegato nella produzione di calore utile al processo di distillazione del greggio. È il contesto della ricerca (pubblicata sulla rivista Energy) condotta dall’ENEA e dall’Università degli Studi di Palermo.
Decarbonizzare i processi industriali
La transizione energetica rappresenta un processo complesso che richiederà un lasso di tempo difficilmente stimabile. Per guadagnare tempo in modo sostenibile è importante sviluppare opzioni tecnologiche volte a decarbonizzare i processi che, allo stato attuale, rendono possibili i nostri standard di vita.
Parlando con i numeri, “realizzare un impianto solare a concentrazione in una raffineria di petrolio permetterebbe di tagliare di oltre il 10% le emissioni di anidride carbonica (circa 54 mila tonnellate/anno) e la quantità di metano utilizzato (circa 20 mila tonnellate/anno) nella produzione di calore utile al processo di distillazione del greggio”. Così, a Energia Italia News, il professor Alessandro Galia dell’Università degli Studi di Palermo.
L’ateneo fondato nel 1806 ha condotto, insieme all’ENEA, uno studio sull’integrazione di un impianto solare a concentrazione nella sezione di distillazione del greggio di una raffineria di petrolio. Coordinata dal professor Galia – e promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca grazie ai fondi PNRR del partenariato esteso pubblico-privato NEST (Network for Energy Sustainable Transition) – la ricerca è visibile sulla rivista Energy.
Ottenere un duplice vantaggio
Continua Galia: “La distillazione del petrolio greggio costituisce uno dei processi più energivori di una raffineria con una domanda di energia complessiva pari a circa il 30-40% del totale”. Pertanto “con questo studio – prosegue – abbiamo dimostrato che il calore prodotto da un impianto solare a concentrazione potrebbe essere integrato in maniera efficace ed economica nel processo di distillazione”.
Raggiungendo, di fatto, due obiettivi: una significativa decarbonizzazione delle attività di raffineria e una riduzione dei consumi di metano, soprattutto per quegli impianti situati in regioni con alta irradiazione solare. Fermo restando, aggiunge Galia, “che l’implementazione pratica dell’integrazione del calore solare è complessa poiché richiede lo sviluppo di una strategia per abbinare, in modo economicamente sostenibile, la natura intermittente della radiazione solare con il funzionamento continuo delle raffinerie”.
Collettori a concentrazione solare
L’impianto ipotizzato nello studio si basa sull’utilizzo di collettori solari lineari lunghi 100 metri ciascuno, con una larghezza di specchi di 5,8 metri, dotati di un tubo ricevitore dove scorre una miscela di sali fusi (“sale solare”) che svolge la funzione di fluido di trasferimento e di accumulo di calore.
“Abbiamo considerato diverse configurazioni dell’impianto rinnovabile variando la potenza solare integrata (50 e 70 MW) e l’estensione del campo solare (80 e 100 stringhe o loop, da 6 collettori solari ciascuna) e impostando una capacità massima del serbatoio di stoccaggio caldo a 800 mila kWh. Tutto ciò grazie alla possibilità di regolare la potenza delle tradizionali fornaci di distillazione e, di conseguenza, ottenere un impianto ibridizzato”, il commento di Giampaolo Caputo, ricercatore del Laboratorio ENEA Energia e Data Science del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili.
Il team di ricerca ha quantificato che la dimensione massima dell’impianto solare a concentrazione è limitata a 100 loop – circa 330 mila metri quadrati di superficie di collettori – e riesce a fornire costantemente al processo il calore solare, compresa la “carica” di accumulo di energia termica per 24 ore di funzionamento durante le giornate serene.
Analisi tecnico-economica
Lo studio condotto dall’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo sostenibile e dall’Università degli Studi di Palermo è stato completato con un’analisi tecnico-economica fondata su un caso ipotetico simulato rielaborando dati reali di funzionamento di una raffineria italiana.
“Lo scenario considerato – riprende Galia – ha permesso di stimare un tasso di ritorno dell’investimento del 16,2% ad indicare che le minori somme spese per l’approvvigionamento di metano e per il pagamento dei costi delle emissioni di anidride carbonica permettono di compensare in un ragionevole lasso di tempo i costi di investimento e di esercizio dell’impianto solare”.
Chiosando così: “L’integrazione del calore solare ad alta temperatura risulterebbe quindi interessante per i siti che operano in zone ad elevato irraggiamento e la cui conformazione garantisca la disponibilità di spazio, indispensabile per l’istallazione del campo solare, in posizione contigua alle unità di distillazione del greggio”.